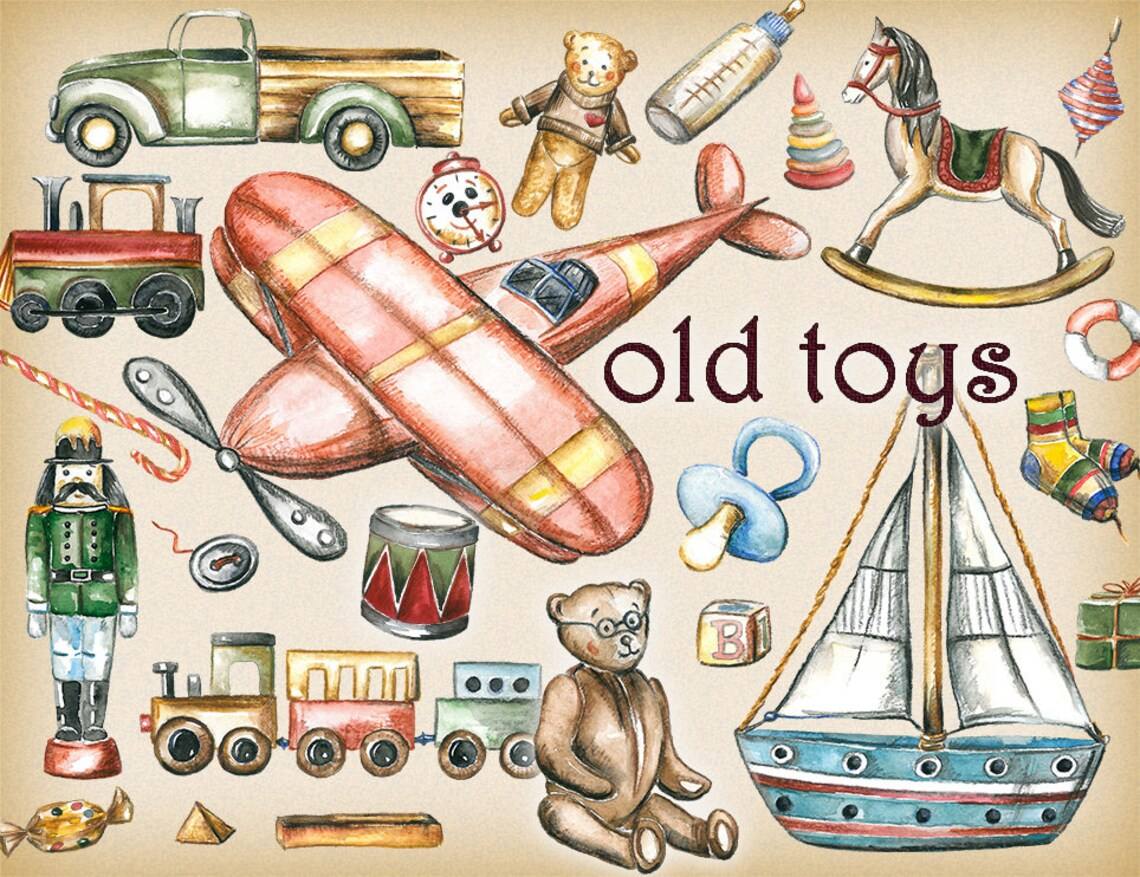
Il gioco è…
di Ieris Astolfi
- Il gioco è un’attività educativa gioiosa, libera, gratificante che permette al bambino e alla bambina, ma non solo, di conoscersi e di “afferrare” il mondo che li circonda. Sul piano educativo il gioco può essere utilizzato: sia come espressione spontanea, sia come strumento che permette di divertirsi giocando insieme (favorisce cioè la socializzazione), sia come strumento che consente all’educatore di raggiungere i suoi obiettivi.
- Il gioco, quello libero e spontaneo non ha finalità produttive esterne, ma è pura soddisfazione interna, lo si fa per sé (differenza quindi col lavoro), senza precisi scopi.
- Il gioco investe tutti i campi del comportamento infantile (ma non solo) e serve per lo sviluppo dell’intelligenza (vedi Piaget), per lo sviluppo dei processi cognitivi (percezione, attenzione, memoria, apprendimento, ecc.) per lo sviluppo affettivo (vedi Freud), per lo sviluppo sociale (vedi Erikson), per lo sviluppo motorio, per lo sviluppo della socializzazione, per lo sviluppo morale (moralità eteronoma e moralità autonoma secondo Piaget) e in generale per interagire con l’ambiente.
- Secondo Freud il gioco soddisfa il desiderio di impadronirsi di una situazione in forma simbolica, esprime il bisogno di crescita permettendo al bambino e alla bambina di agganciare l’attività fantastica; per Freud il gioco ha origine nella vita inconscia e il simbolismo inconscio assicura un migliore equilibrio emotivo. Il timore e l’ansia che il bambino o la bambina può provare nei confronti di determinate situazioni, possono venire ridotte, e quindi gradualmente dominate, attraverso la ripetuta rappresentazione ludica della situazione che è alla loro origine (ad esempio ripetere lo stesso gioco e la stessa favola). Impulsi e desideri che non potrebbero trovare soddisfacimento sul piano concreto, perché l’ambiente fisico o sociale non lo consentono, possono esprimersi su oggetti simbolo (per esempio l’aggressività verso un membro della famiglia può trovare espressione nel trattamento riservato al bambolotto). Per Freud: “Il contrario del gioco non è ciò che è serio, bensì ciò che è reale”.
- Secondo Frobel (1800, sarà proprio il romanticismo con Frobel a costruire una concezione del gioco anticipatrice della pedagogia moderna) il gioco è il “lavoro” del bambino.
- La parte più suggestiva del gioco è la “vittoria della fantasia”, la dimensione fantastica raggiungibile; è possibile trasformare oggetti più poveri in velieri, isole lantane, le persone in feroci pirati o coraggiosi Robin Hood, ecc. e tutto questo aiuta il bambino e la bambina ad indirizzare positivamente (e a scaricare) ansie e aggressività; è un educativo allontanarsi (spaesamento rassicurante) e ritornare alla realtà.
- Il gioco nei primi anni di vita è strettamente connesso con il concetto di amicizia: essere amico vuol dire giocare insieme, questa condizione è l’inizio del lungo percorso che porta allo sviluppo del concetto di amicizia.
- Giocare è una cosa seria: l’articolo 31 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (1990) esprime le valenze fondamentali del diritto al gioco. Il diritto al gioco non è un lusso ma una componente imprescindibile del diritto all’educazione.
- I giochi collettivi dei bambini e delle bambine, come palla prigioniera, i quattro cantoni, nascondino, ecc., sviluppano il senso sociale e un simbolismo capace di fornire addirittura strumenti cognitivi di difesa contro futuri pericoli reali.
- Il gioco, in sostanza, è una situazione in cui si sperimentano a rischio zero, o comunque minore, comportamenti altrove più insidiosi in una logica di laboratorio o per meglio dire “prova generale del futuro”, preparare i giovani alla vita o di “allenamento” per la vita quotidiana. Il bambino e la bambina, mentre gioca, sta facendo le prove tecniche per affermare la propria indipendenza, provare le proprie energie, testare la personalità, applicare strategie “difensive”, costruire sé ed il proprio mondo, prendere padronanza del proprio corpo ed esplorare l’ambiente. Nel gioco emergono poi quegli elementi di gratuità, impegno, passione, ecc … che a volte ritroviamo negli adulti che si impegnano in ruoli fondamentali della società civile, come ad esempio nel campo del lavoro. Questo dimostra che all’interno del gioco vi sono “profetiche” potenzialità che vanno sviluppate.
- Secondo Bruno Munari (artista, illustratore per l’infanzia e designer italiano, 1907-1998) il gioco richiede la partecipazione globale dell’individuo ed è quindi importantissimo per lo sviluppo cognitivo: esso stimola infatti un apprendimento più intenso e una memorizzazione più facile. Il gioco si basa infatti, più di altre attività, sul fare, cioè sul contatto diretto con gli oggetti e ciò consente di capire. Secondo Munari, il bambino tramite il gioco è in grado di apprendere quasi tutto, ma non solo poiché chi riuscirà a conservare integralmente le sue capacità di gioco, diventerà un adulto creativo e addirittura un artista o uno scienziato, perché artisti e scienziati sono uomini che non hanno mai smesso di giocare
- Un vecchio proverbio cinese di Confucio afferma che: “Se vedo dimentico, se ascolto ricordo, se faccio capisco”. Il gioco rientra a pieno titolo nel “fare”.
- Secondo lo psicoanalista austriaco Bruno Bettelheim (1903-1990), il gioco di fantasia opposto alla fantasia pura costituisce un ponte tra il mondo inconscio dentro di noi e la realtà esterna intorno a noi; la fantasia e la realtà si aiutano l’una con l’altra, perché la fantasia senza realtà è asociale e caotica, mentre la realtà senza la fantasia è aspra e fredda.
- Il poeta cileno Pablo Neruda (1904-1973) disse: “Il bambino che non gioca non è un bambino e un adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino interiore che è in lui”
- La versatilità del gioco possiamo riassumerla nei seguenti vantaggi che offre: stimola la fantasia; stimola lo sviluppo del pensiero astratto; favorisce la relazione, la cooperazione, il contatto e il confronto con l’altro; mette a conoscenza dei propri limiti, ma anche delle proprie qualità e del proprio carattere; educa a rapportarsi con ruoli e regole; fa fare esperienze di divertimento e di rilassamento, stempera tensioni e paure; aiuta ad elaborare strategie ed aumenta le capacità di analisi di una situazione reale; favorisce una crescita armonica a livello psicofisico; stimola l’individuo a compromettersi, a mettersi in gioco; favorisce l’immedesimazione in situazioni piacevoli e fantastiche; soddisfa la voglia di protagonismo; aiuta nella ricerca di verifiche, di autostima, che definiscano la propria identità e il proprio ruolo nel “branco di appartenenza”; fa bene alla salute, dispone al buon umore e ad un temperamento aperto ed ottimista.
- Il bambino non gioca per imparare, ma impara giocando.
- “Se giochi a fare il genio, poi lo diventi” (Salvador Dalì).



